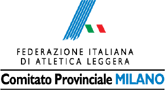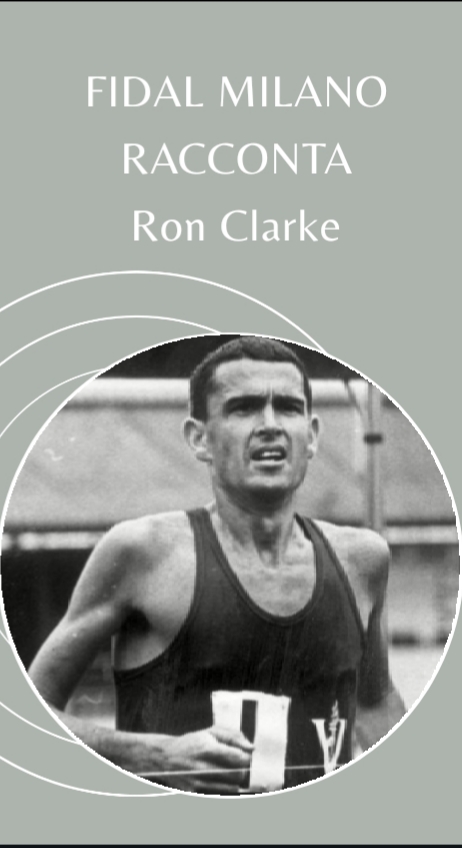
La medaglia d’oro olimpica, quella che non vinse mai sulle piste d’atletica, arrivò in modo speciale. E con una dedica altrettanto speciale. Luglio del 1966, Ron Clarke, l’uomo che demoliva record mondiali senza riuscire ad essere il migliore alle Olimpiadi, era stato invitato al meeting di Praga, e ad invitarlo era stato una leggenda del mezzofondo. Emil Zatopek in persona lo aveva guidato, dopo la gara, per le strade di Praga, la sua amatissima città, scortandolo a sera fino all’aeroporto, dove lo aspettava l’aereo che lo avrebbe portato a Londra, per un altro impegno sulle piste. Fu allora che Ron si rese conto di cosa rappresentasse Zatopek per la sua gente: insieme superarono la dogana, con un semplice saluto della “Locomotiva umana” alle guardie, e raggiunsero la scaletta dell’aereo, a bordo pista.
In quel momento, prima di sparire inghiottito dalla sera, Zatopek consegnò a Clarke un minuscolo pacchetto, salutandolo con un abbraccio. Per un paio d’ore il campione australiano si interrogò sul contenuto, arrivando a formulare anche le ipotesi più fantasiose: Emil si era dimostrato un amico sincero, ma vai a sapere quello che passa per la testa a uno che ti fa saltare tutte le barriere per agevolarti l’imbarco. E se quell’involucro avesse nascosto qualcosa di vietato dalla legge, per dire?… Ron si ripromise di aprire quel dono soltanto una volta atterrato a Londra, ma poi non seppe resistere alla curiosità e lo scartò. Dentro, trovò una medaglia d’oro olimpica, quella che Zatopek aveva vinto nei 10.000 metri ad Helsinki, nel 1952. Con una dedica, incisa appositamente: “A Ron Clarke, 19 luglio 1966. Non solo per amicizia, ma perché la meriti”.
La meritava davvero, Ron Clarke. Ma non la vinse mai. Tutti lo trattavano come un predestinato, fin da quando, all’apertura dei Giochi di Melbourne, nella sua Australia, gli era toccato l’immenso onore di accendere il tripode, a neppure diciannove anni. Già allora era una promessa: aveva corso il miglio in 4’19”4 e le 2 miglia in 9’17”8 nel 1955, ad appena diciassette anni, e in quell’anno olimpico stampò un impressionante 4’06”8, sempre sul miglio. Mancò di poco la qualificazione olimpica, ma si guadagnò quella passerella che era una promessa di futuro. Di lì a poco avrebbe iniziato la sua corsa incredibile verso il vertice, che lo portò a superare per ben diciassette volte i limiti scritti sui libri dell’atletica. Inanellando primati mondiali dalle 2 miglia all’ora in pista. Sempre affrontando la vita, e la corsa, con ironia ed eleganza.
Come quando raccontava della prima volta, quel 18 dicembre 1963 in cui corse i 10000 metri in 28’15”6 nella sua Melbourne. Facendolo come nessuno l’aveva fatto prima. “Avevo lasciato la macchina a mia moglie Helen, che doveva portare i bambini a una festa. Così, uscito dal lavoro, mi feci a piedi le due miglia che mi separavano dall’Olimpic Park. Corsi e feci il mio primo primato. Poco più tardi, raggiunsi la famiglia alla festa, sempre a piedi, e dissi a mia moglie: ho fatto il record del mondo. Lei sorrise, felice ovviamente, e disse: fantastico… mentre me lo racconti, puoi darmi una mano a preparare i sandwiches?” Questo era Ron Clarke. Uno che prendeva l’atletica seriamente, tanto da diventare il primo della lista, ma allo stesso tempo sapeva dare alle cose il loro valore. “L’ho amata da morire, e se non ho vinto nessuna medaglia d’oro, significa che doveva andare così. Ho dato il massimo. E dopo quegli anni, ho amato il resto della mia vita, la mia famiglia, il mio lavoro”.
Aveva dato il massimo anche il 14 ottobre 1964, nella finale unica dei 10.000 alle Olimpiadi di Tokio, trentasette runners in pista a cercare gloria. Ci era arrivato da primatista del mondo, i riflettori puntati addosso. E nell’ultimo rettilineo aveva cercato di rispondere all’attacco del tunisino Mohamed Gammoudi, certamente dotato di un finale di gara più acceso. Ma entrambi non avevano fatto i conti con un “underdog”, uno di quelli che non godono dei favori del pronostico, nemmeno tra gli addetti ai lavori. Non aveva neppure vinto i trials Usa, Billy Mills, preceduto nell’occasione da Gerry Lindgren. Ma era lì, nel giorno giusto e al momento giusto, e con una volata micidiale li infilò entrambi. Per Ron Clarke, il più veloce al mondo, soltanto una medaglia di bronzo. L’unica della sua carriera olimpica.
Quattro anni dopo, a Città del Messico, la sua corsa a cinque cerchi finì con toni drammatici. Arrivato all’appuntamento in cima alla lista mondiale all-time (e anche primatista stagionale) sia nei 5000 che nei 10000, rimediò soltanto delusioni. Nella distanza più lunga, nonostante una lunga preparazione sulle Alpi, pagò più di altri i problemi legati all’altitudine. Finì sesto, a 17 secondi dal vincitore Naftali Temu, ma le foto scattate immediatamente dopo l’arrivo lo ritraggono con la maschera dell’ossigeno sul viso, attorniato da medici e personale di servizio che tengono monitorato il suo stato di salute. “Di quell’ultimo giro non ricordo nulla. Ero sprofondato dentro un grande buio”.Quattro giorni dopo, nella finale dei 5000, non sarebbe riuscito a raddrizzare quel destino beffardo, nemmeno cercando di dettare il ritmo nella prima parte della gara. Il solito finale lo aspettava al varco a un chilometro dal traguardo, quando i corridori d’Africa, che sull’esempio di Abebe Bikila iniziavano a fare la voce grossa a livello internazionale, iniziarono a sfilarlo e a scappargli via. Primo, proprio Gammoudi. Secondo e terzo i keniani: Kip Keino e ancora Temu. Quarto il campione di casa, il messicano Juan Maximo Martinez, evidentemente a suo agio in quelle condizioni particolari e pressoché irripetibili.
Niente da fare. Gli mancava lo spunto, doveva correre sul ritmo. E quando ci riusciva, lo faceva come nessun altro al mondo. Stroncando la resistenza di qualunque avversario. Come accadde il 14 luglio 1965, nella gara dei 10000 metri sulla gloriosa pista di Oslo. Ci era arrivato da primatista del mondo, finì col battere sé stesso con un risultato che spostava i criteri di valutazione, e proiettava tutto il movimento in una nuova era. Corse in perfetta solitudine, quel giorno, rifilando un minuto e quaranta secondi al britannico Hogan, secondo classificato) e spostò il limite di 36 secondi e 2 decimi. In un colpo solo. Come fosse sceso da un altro pianeta, né più né meno. Moderno e unico era anche nel presentarsi al mondo, con quelle canotte fatte in casa che erano uno spettacolo, e che rimandavano sempre il pensiero alla sua terra e alla sua gente, in qualunque parte del mondo si trovasse. Moderno e diverso fu nelle scelte di vita. Generoso, elegante, pronto a mettersi in gioco per gli altri. Una “vocazione” particolarmente apprezzata a Gold Coast, la città del Queensland di cui si era innamorato durante una vacanza con Helen nel 1957, e nella quale sarebbe tornato quasi ogni anno fino a stabilircisi definitivamente nel 1995: i cittadini (oltre mezzo milione di abitanti) di questa terra affacciata sull’oceano, di spiagge infinite, sole che riscalda e cuori innamorati persi dietro ai loro surf, decisero nel 2004 che Ron Clarke avrebbe dovuto diventare “major”. E lui restò il loro sindaco fino al 2012, tre anni prima di andarsene per sempre.
Il cuore aveva dato i primi segnali di affaticamento nel 1972, due anni dopo il ritiro dalle scene, e nel 1983 proprio un innocuo allenamento di corsa lo aveva mandato in fibrillazione, e c’era voluta un’operazione perfettamente riuscita per sistemare una valvola difettosa. L’addio arrivò a causa di un’insufficienza renale, nel giugno 2015. Un mese esatto prima del cinquantesimo anniversario di quel record incredibile ottenuto sulla pista di Oslo. Impossibile etichettare Ron Clarke come un perdente. Le sue vittorie, a rileggerle bene, sono anche nella vita dopo l’atletica, quella di uomo d’affari prima e di amministratore pubblico poi. Prese questi impegni con la stessa passione e la stessa determinazione con cui aveva lavorato per migliorarsi e assicurarsi un posto tra i grandi del mezzofondo. Nel grande libro dell’atletica, è entrato da precursore.Arrivando a correre, oltre cinquant’anni fa, i 10000 con quel “crono” stratosferico, 27’39”4, ma anche i 5000 in 13’16”6, e a percorrere 20,323 chilometri nell’ora in pista. “Ero un corridore dallo stile molto semplice. Mi piaceva azzardare, cercare sempre di andare ad esplorare i miei limiti, correre da “front runner” cercando di viaggiare più veloce che potevo. A volte la cosa ha funzionato, a volte no”. Ma quando ha funzionato, accidenti, sono state pagine indimenticabili per l’atletica leggera. Zatopek, che lo aveva capito prima di tutti, lo ricompensò con una medaglia d’oro che non aveva eguali.
Marco Tarozzi – (da Runner's World, febbraio 2018)
SEGUICI SU: Instagram @atletica_milano | Facebook www.facebook.com/fidalmilano | Twitter @fidalmilano